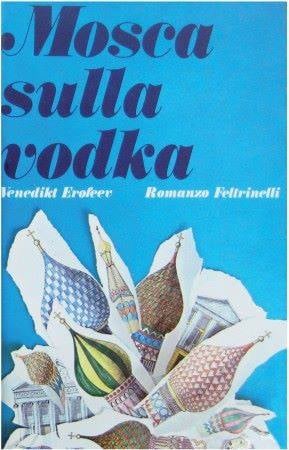Capolavoro sommerso della letteratura sovietica, spesso banalizzato come la “risposta russa a Bukowski”, ma in realtà molto più vicino a Gogol’ o a un Dostoevskij in coma etilico.
Scritto tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta, circolò in Unione Sovietica come samizdat, cioè in forma clandestina, durante gli anni plumbei della stagnazione brezneviana. Tradotto per la prima volta in Israele nel 1973, poi in Francia e in Italia (Feltrinelli), il testo divenne presto un cult sotterraneo, simbolo della disperazione ironica dell’intellettuale sovietico disilluso
Il romanzo racconta un viaggio in treno di appena centocinquanta chilometri, da Mosca alla cittadina di Petuški, trasformato da Erofeev in una vertigine alcolica e metafisica.
Lungo il percorso, reale e insieme allucinatorio, il protagonista – un ubriacone lucido, un filosofo dei bar, un poeta della sconfitta – attraversa paesaggi interiori e stazioni simboliche che diventano la mappa deformata della società sovietica.
Violento, sarcastico, eppure intriso di pietà e malinconia, Mosca – Petuški è una satira feroce e una parabola esistenziale: un viaggio dentro il delirio di un uomo e, attraverso di lui, nella follia di un intero sistema.
Tra iperboli, citazioni bibliche e paradossi comici, Erofeev costruisce un’epica del fallimento, dove la miseria quotidiana si trasfigura in poesia e il reietto diventa eroe tragico.
Nel finale, la corsa si dissolve in una rivelazione tragica e beffarda: la realtà e il sogno collassano, lasciando il lettore in sospensione tra tragedia e farsa.
Negli anni Settanta e Ottanta il libro divenne un culto per pochi, poi scivolò nell’oblio dei capolavori dimenticati — quelli che non invecchiano, ma continuano a fermentare sotto la superficie del tempo.