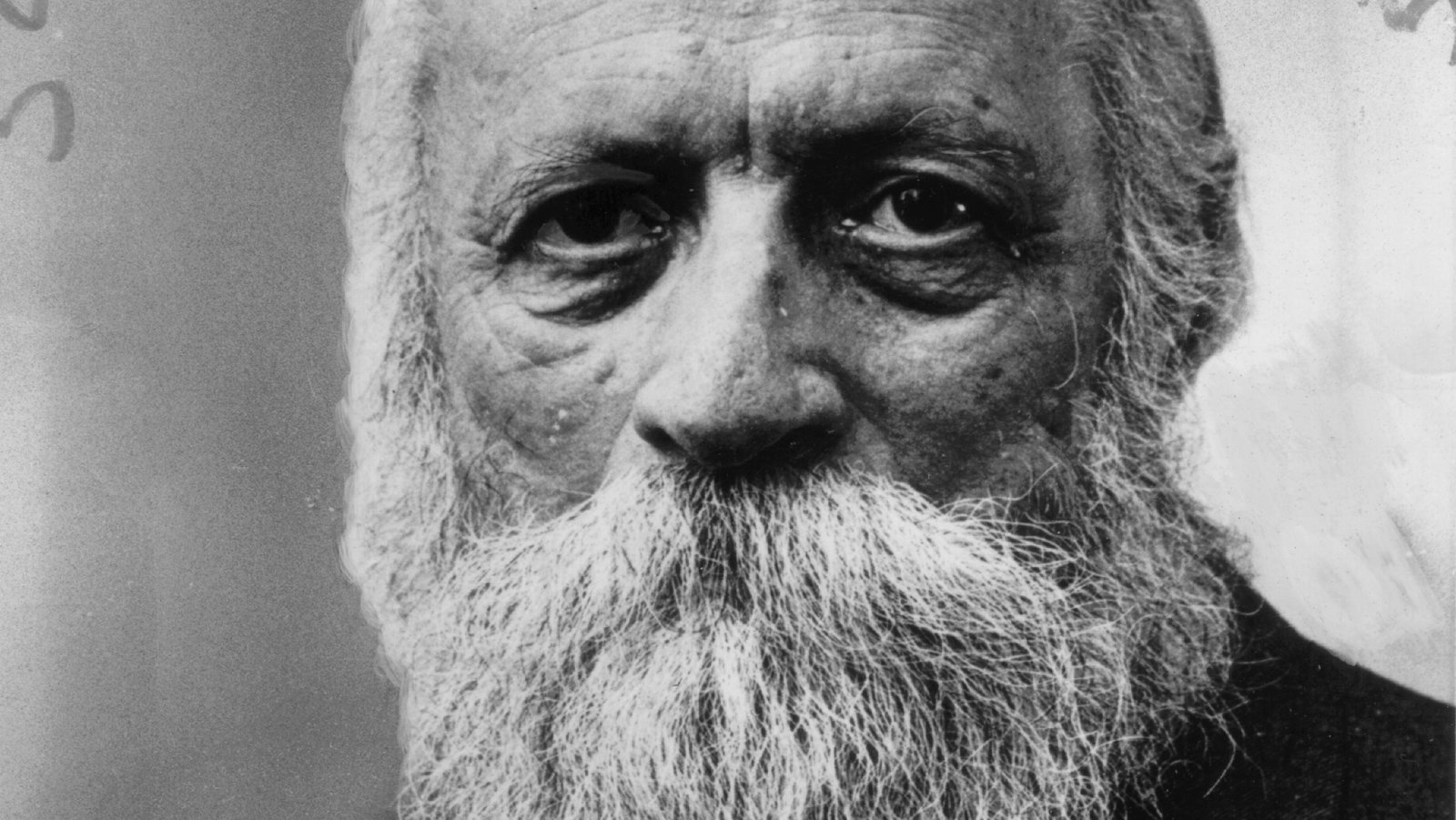L’approdo di Martin Buber al chassidismo non ha nulla dell’adesione immediata né della riscoperta nostalgica. È, piuttosto, l’esito di una traiettoria intellettuale segnata da una progressiva insofferenza nei confronti tanto dell’ebraismo ridotto a identità culturale quanto di quello irrigidito in sistema normativo autosufficiente. Formatosi all’interno della filosofia europea tra fine Ottocento e primo Novecento, Buber attraversa il romanticismo, Nietzsche, Dilthey, per poi constatare l’insufficienza di ogni pensiero che separi il senso dalla vita, il significato dall’esistenza concreta.
È solo a partire da questa crisi che il chassidismo si impone come possibilità filosofica prima ancora che religiosa, non una dottrina mistica da decifrare, ma una grammatica dell’esistenza in cui la relazione precede il concetto e la presenza sostituisce la spiegazione. Ciò che Buber riconosce nel chassidismo non è un sapere alternativo, ma una forma di esperienza in cui l’incontro con D-o non avviene per astrazione o elevazione, bensì nel punto di massima immanenza del vivere quotidiano. La devekut non designa uno stato eccezionale, ma una intensificazione dell’attenzione al reale, un abitare il mondo senza sottrarsi ad esso.
In questo senso lettura buberiana è consapevolmente anti-sistematica. I racconti chassidici, le figure dei tzaddikim, le parabole non vengono ordinati in una teologia coerente, perché ciò che è in gioco non è un contenuto dottrinale, ma un evento relazionale che si dà solo nella singolarità dell’incontro. In questo senso, il chassidismo diventa per Buber una critica implicita tanto al legalismo quanto allo spiritualismo con derive esoterche, alla Legge che pretende di valere senza relazione, e alla relazione che pretende di fare a meno della forma.
Anche la mitzvà, allora, viene sottratta alla logica dell’esecuzione automatica. Non è abolita, ma restituita alla sua origine dialogica: vale non come gesto ripetuto, ma come risposta. Senza relazione, la norma si svuota; senza norma, la relazione si dissolve. Il chassidismo buberiano vive di questa tensione.
In questa prospettiva, l’ebraismo non appare più come religione nel senso moderno, né come identità da possedere, ma come modalità dell’esistere davanti a D-o, all’altro, al mondo. È per questo che Buber resta inattuale e scomodo: perché il suo ebrasimo filtrato dal chassidismo non offre consolazioni né appartenenze protettive, ma espone l’individuo a ciò che la modernità tende a eludere, ossia il rischio dell’incontro. Un ebraismo che chiama, e chiede, ogni volta, una risposta.
È solo a partire da questa crisi che il chassidismo si impone come possibilità filosofica prima ancora che religiosa, non una dottrina mistica da decifrare, ma una grammatica dell’esistenza in cui la relazione precede il concetto e la presenza sostituisce la spiegazione. Ciò che Buber riconosce nel chassidismo non è un sapere alternativo, ma una forma di esperienza in cui l’incontro con D-o non avviene per astrazione o elevazione, bensì nel punto di massima immanenza del vivere quotidiano. La devekut non designa uno stato eccezionale, ma una intensificazione dell’attenzione al reale, un abitare il mondo senza sottrarsi ad esso.
In questo senso lettura buberiana è consapevolmente anti-sistematica. I racconti chassidici, le figure dei tzaddikim, le parabole non vengono ordinati in una teologia coerente, perché ciò che è in gioco non è un contenuto dottrinale, ma un evento relazionale che si dà solo nella singolarità dell’incontro. In questo senso, il chassidismo diventa per Buber una critica implicita tanto al legalismo quanto allo spiritualismo con derive esoterche, alla Legge che pretende di valere senza relazione, e alla relazione che pretende di fare a meno della forma.
Anche la mitzvà, allora, viene sottratta alla logica dell’esecuzione automatica. Non è abolita, ma restituita alla sua origine dialogica: vale non come gesto ripetuto, ma come risposta. Senza relazione, la norma si svuota; senza norma, la relazione si dissolve. Il chassidismo buberiano vive di questa tensione.
In questa prospettiva, l’ebraismo non appare più come religione nel senso moderno, né come identità da possedere, ma come modalità dell’esistere davanti a D-o, all’altro, al mondo. È per questo che Buber resta inattuale e scomodo: perché il suo ebrasimo filtrato dal chassidismo non offre consolazioni né appartenenze protettive, ma espone l’individuo a ciò che la modernità tende a eludere, ossia il rischio dell’incontro. Un ebraismo che chiama, e chiede, ogni volta, una risposta.