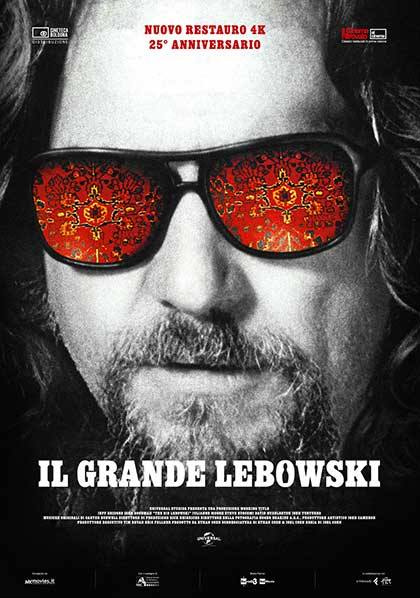Il Grande Lebowski capolavoro e apoteosi del cinema postmoderno: citazioni, ironia, metanarrativa e decostruzione del mito americano. I Coen, ebrei erranti nel deserto hollywoodiano, giocano col noir come un rabbi con il Talmud, ribaltandone ogni dogma, svuotandolo dall’interno, trasformando l’eroe hard-boiled in un hippy strafatto. Il Dude è l’anti-Bogart, il Marlowe ridotto a detrito pop, il nichilismo che affoga in un white russian.
E con lui una galleria di personaggi folli e indimentcabili: dal paranoico Walter Sobchak, al tronfio Mr. Lebowski, allo schizzatissimo Jesus interpreato da Turturro, poi i Nichilisti, Jackie Treehorn, Brandt, Bunny Lebowski, Smokey, The Stranger, Woo, Knox Harrington e così via.
Nel grande Lebowksy i Coen costruiscono il caos con un rigore maniacale, alternano piani sequenza onirici e inquadrature da cinema classico, si divertono a sovvertire il linguaggio cinematografico, la fotografia è Seventies, satura di colori, la colonna sonora è un collage schizofrenico geniale che va dai First edition a Elvis ai Monks, passando per Hotel California nella delirante versione dei Gypsy Kings , mentre il montaggio alterna la lentezza sorniona del Dude a esplosioni improvvise di violenza slapstick. Citazionista fino alla parodia, dal Hawks di Il grande sonno all’Altman di Il lungo addio, passando per l’ossessione felliniana del sogno e la commedia assurda di Sturges, Il Grande Lebowski è un manifesto sul fallimento, dove nulla ha senso ma tutto è connesso. E alla fine tutto si risolve, cabalisticamente, nel vuoto. Il mistero non ha soluzione, perché il mistero non esiste. Il tappeto non verrà mai restituito, il rapimento non è mai stato reale, la giustizia non è mai stata un’opzione. Il cinema noir insegnava che sotto la superficie dell’apparenza si celava una verità più oscura. Il Grande Lebowski invece ci dice che sotto non c’è nulla.