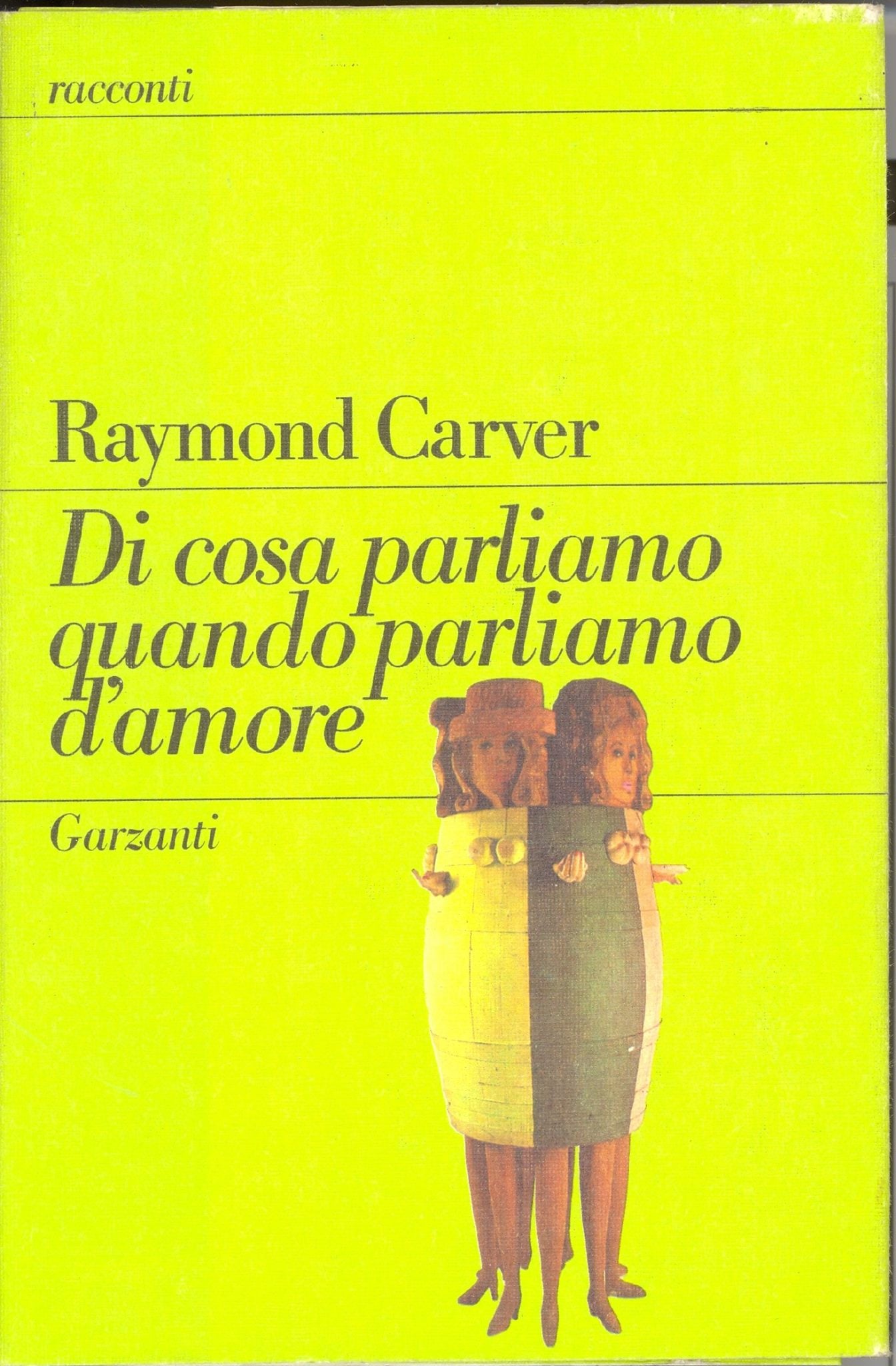Premetto: non sono mai stato un grande amante di Carver. Ho sempre preferito al suo minimalismo l’universo paranoico di Pynchon, la geometria malata di DeLillo, l’ebraismo conflittuale di Roth o la verbosità quasi barocca di Barth. Eppure questa raccolta, che riunisce diciassette racconti scritti nei primi anni Settanta, rimane — al di là di ogni idiosincrasia — un capolavoro assoluto della letteratura americana del secondo Novecento.
“Di cosa parliamo quando parliamo d’amore” uscito nel 1981 è una raccolta di racconti brevi che si muove ai margini del reale, dove il quotidiano diventa enigma e il silenzio è la vera grammatica dei rapporti umani.
Le storie di Carver sono minimaliste ma mai minime: la scrittura è asciutta, tagliata all’osso, ma non glaciale. È un linguaggio di sottrazioni e risonanze, in cui ogni frase pesa più per ciò che tace che per ciò che dice. C’è una lucida precisione nel modo in cui Carver smonta la realtà, la espone nella sua banalità feroce, la lascia pulsare come un piccolo trauma.
I racconti spiazzano, non cercano empatia ma un disagio sottile. L’effetto è quello di un vuoto che si apre sotto la superficie di situazioni comuni: una cena, una conversazione, un bicchiere di gin. Dietro questi frammenti di vita ordinaria si intravedono solitudini inespresse, amori corrosi, violenze trattenute, rimpianti.
La domanda che ci si pone dopo ogni storia non è tanto “cosa succede”, quanto “cosa mi è sfuggito?”. Perché Carver ci costringe a interrogarci su ciò che resta fuori dal testo, il non detto, l’implicito, il possibile.
Alla fine, tra le pieghe dei suoi silenzi, affiora la risposta alla domanda del titolo: di cosa parliamo, quando parliamo d’amore? Parliamo di solitudine, di rabbia, di morte, di sesso e di paura; parliamo di noi stessi, di ciò che rimane quando le parole si spengono.
È in questa zona d’ombra, in questo spazio di ambiguità morale e linguistica, che Carver ha costruito una delle poetiche più influenti del secolo. Un libro che non consola, non spiega, ma continua a ferire con la stessa lucidità del primo giorno.