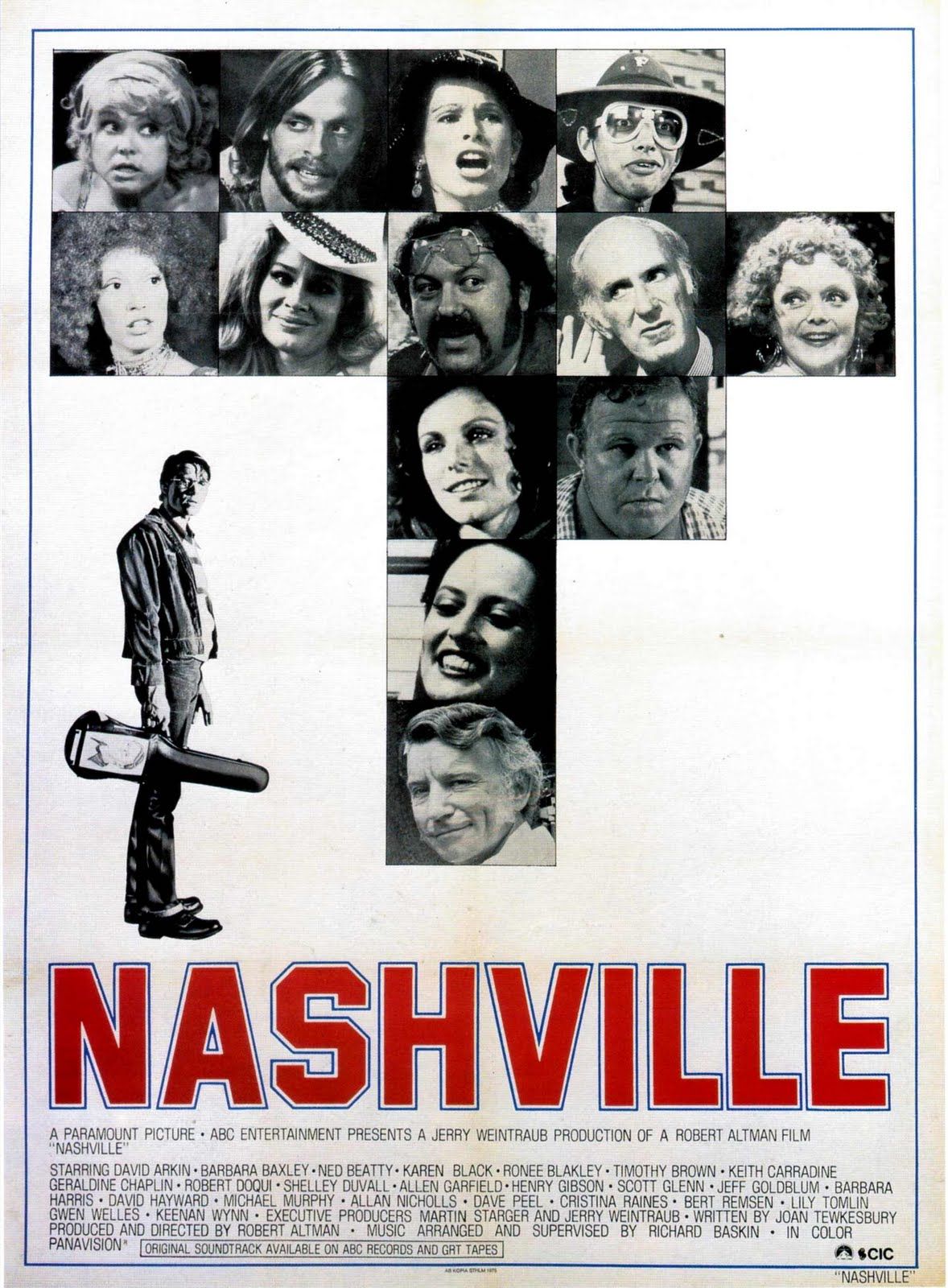Film corale che sovverte la linearità narrativa per restituire un affresco liquido, polifonico, in cui la Storia si intreccia alle storie individuali.
L’America post-Watergate, sospesa tra disillusione e intrattenimento spettacolarizzato, si riflette in un microcosmo caotico e al contempo calibratissimo: una città-mito dell’ immaginario Americano in cui il country diviene la colonna sonora della fine dell’epoca dell’innocenza.
Altman, maestro della narrazione rizomatica, costruisce Nashville come una struttura sferica, dove il tempo non è vettoriale ma circolare, un sistema di orbite in cui i personaggi gravitano e si sfiorano senza mai comporsi in un disegno univoco. L’innocenza, qui, non si dissolve con un atto definitivo, ma si sfalda progressivamente, erosa dall’esposizione al mercato, alla politica-spettacolo, all’inesorabile trasformazione della società americana in un’industria dell’immagine e del consenso.
L’uso del sonoro è emblematico: le voci si sovrappongono, si disperdono in un montaggio anti-gerarchico, dove nessuna figura domina il racconto e l’illusione di un punto di vista onnisciente si frantuma in una polifonia babelica. La macchina da presa si muove con fluidità documentaristica, alternando zoom aggressivi e panoramiche che rifiutano il primato dello sguardo singolare, restituendo invece la complessità di un mondo in transizione.
Il finale, con la celebre sequenza dell’attentato e la canzone It Don’t Worry Me, è il compimento di questa poetica della dissoluzione: il trauma si consuma in diretta, ma il meccanismo dello spettacolo non si arresta. L’America che Altman ritrae è un corpo che vacilla, ferito ma implacabilmente performativo, condannato a intrattenere anche di fronte alla propria catastrofe. In questo senso, Nashville è una tragedia moderna senza catarsi, un requiem in cui la fine dell’innocenza si confonde con l’eterno ritorno della finzione.
David Pacifici