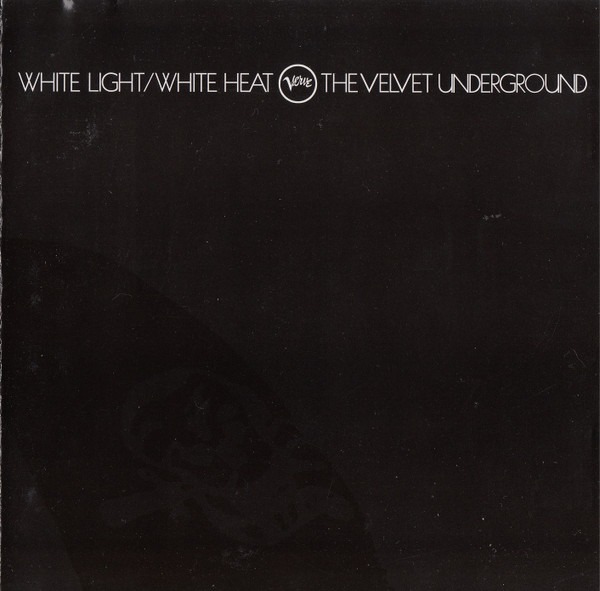Opere feroce e irriducibile, un secondo album che non è un’evoluzione, ma un sabotaggio sistematico di ogni premessa posta dal precedente. Se The Velvet Underground & Nico era stato una vertigine estetica, un esperimento di lirismo tossico e decadentismo pop, il suo successore ne rovescia l’immagine, ne brucia le superfici e ne espone il metallo fuso.
Registrato in fretta, all’inizio del 1968, presso gli A&R Studios di New York, il disco è figlio di un contesto terminale: Lou Reed e John Cale ai ferri corti, Nico e Warhol ormai espulsi dal quadro, e una tensione interna che diventa materia sonora. La produzione è volutamente opaca, granulosa, quasi offensiva nei confronti della chiarezza uditiva. Tutto è saturato, distorto, esasperato: un gesto di distruzione estetica che anticipa, con lucidità involontaria, l’ethos del punk e la sensibilità del noise e dell’industrial.
Tecnicamente, White Light/White Heat rappresenta l’abdicazione consapevole alla competenza tradizionale. I Velvet si fanno fautori di un’estetica del rumore come verità ultima, come smascheramento della convenzione musicale. Il suono, impastato e sbilanciato, dissolve il concetto di “mixaggio” per trasformarsi in corpo bruto, in urto acustico. In “Sister Ray”, venti minuti di trance elettrica e indecente, il gruppo dissolve la forma-canzone in un flusso entropico di feedback, distorsioni e narrazioni pornografiche: un’improvvisazione che è insieme blasfemia e filosofia, parodia e rivelazione.
L’album nel suo complesso è un trattato di radicalità sonora e concettuale. “White Light/White Heat”, il brano d’apertura, è un’epifania di violenza anfetaminica; “The Gift”, con il monologo deadpan di Cale che recita un racconto di Lou Reed, trasforma la narrativa in installazione sonora, come se Burroughs avesse trovato un microfono. “Lady Godiva’s Operation” è un piccolo poema di anatomia e orrore, mentre “I Heard Her Call My Name” disintegra il blues attraverso la nevrosi elettrica della chitarra.
All’uscita, il disco fu accolto con diffidenza, quando non con aperta repulsione. La critica non sapeva come gestirne l’eccesso, la brutalità priva di ironia, la mancanza di compromessi.
Persino i fan più coraggiosi di Warhol ne restarono spiazzati. Ma proprio in questa incomprensione si misura la sua grandezza: White Light/White Heat non è fatto per piacere, ma per ferire la sensibilità estetica del proprio tempo. È un atto di iconoclastia, una negazione del pop come linguaggio conciliante, una dichiarazione di guerra contro l’ascolto come consumo.
Col tempo, il disco è diventato una sorta di reliquia profana, un testo fondativo per tutta la musica che ha cercato di oltrepassare il bello per arrivare al vero. Dalla furia rumorista dei Sonic Youth alla depravazione cerebrale dei Suicide, dal proto-punk dei Stooges all’astrazione di Brian Eno e Throbbing Gristle, tutto ciò che ha interrogato il suono come esperienza limite deve qualcosa a quella notte bianca e calda del 1968.
White Light/White Heat rimane un documento di disobbedienza estetica, un’esperienza di entropia. È la negazione del silenzio e della forma, la volontà di ridurre la musica al suo residuo più fisico, più impuro, più umano. Un grido che non vuole essere ascoltato, ma ricordato come si ricorda un trauma.