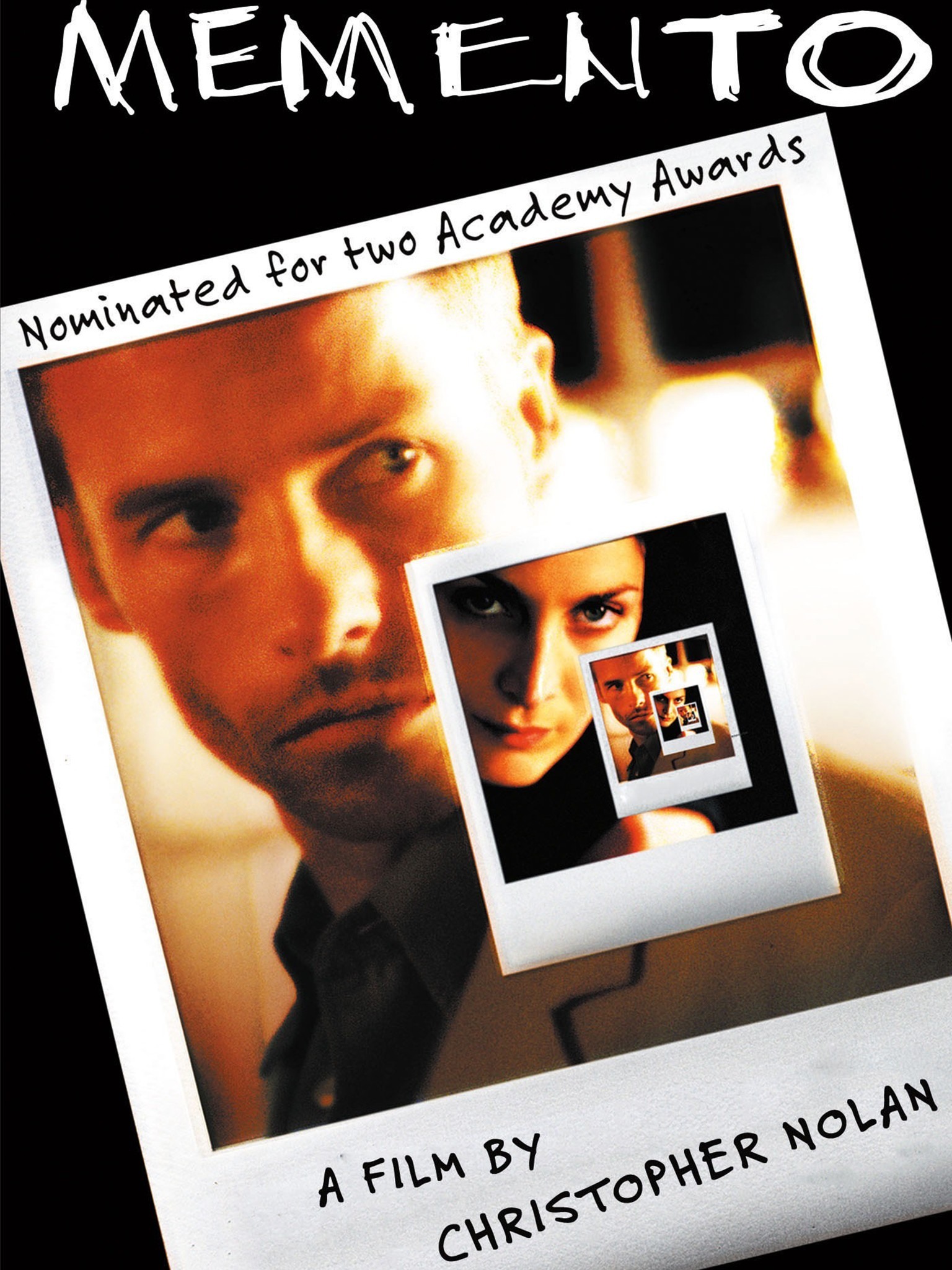In Memento (2000), Christopher Nolan compone un’opera labirintica e vertiginosa che non si limita a raccontare la frammentazione della memoria, ma ne fa il fondamento stesso della struttura narrativa, elevando il medium cinematografico a dispositivo epistemologico: un cinema che non rappresenta la conoscenza, ma la mette in crisi, ne mostra l’inattendibilità costitutiva.
Già Blow-Up di Antonioni e The Conversation di Coppola avevano dischiuso le prime fenditure nella fiducia moderna verso l’oggettività della percezione. Entrambi i film, sebbene inquieti, restavano ancora incardinati in un paradigma in cui esiste un reale che sfugge, che si cela, ma che, almeno in teoria, si potrebbe ancora afferrare. Memento, invece, si situa oltre, in piena temperie postmoderna, dove non è il reale a sfuggire: è la sua stessa esistenza ad essere problematizzata. Nolan non ci dice che la verità è difficile da cogliere, ma che essa è strutturalmente inaccessibile, forse perfino inesistente al di fuori delle narrazioni – menzognere ma necessarie – che costruiamo.
Leonard Shelby, l’antieroe tragico del film, affetto da un’amnesia anterograda, è costretto a vivere in un eterno presente, sprovvisto di continuità temporale, affidandosi a tatuaggi e polaroid per orientarsi in un mondo che egli stesso contribuisce a deformare. Ma ciò che più inquieta non è la sua perdita di memoria, bensì la sua capacità, o piuttosto volontà, di manipolarla.
La memoria non è più garanzia di identità, bensì strumento di autoinganno. Leonard si trasforma in demiurgo tragico di una narrazione apocrifa, dove la verità è sacrificata sull’altare del senso, e la conoscenza è subordinata all’illusione consolatoria del “credere”.
Nolan, con una struttura narrativa che si dispiega à rebours, costringe lo spettatore a condividere l’inferno epistemico del protagonista: la sequenza temporale viene disgregata, il principio di causalità decostruito, e l’identità personale rivelata come una fragile finzione, un collage disgiunto di percezioni e narrazioni selettive. Il montaggio diventa così non solo stile, ma filosofia: la forma è il contenuto. Ogni scena retrocede verso la propria premessa, in un’inarrestabile regressione che non culmina in un’origine ma in un vuoto, in un’assenza fondativa. Non c’è un “prima” autentico da cui partire, non c’è verità da disseppellire, ma solo il bisogno, profondamente umano, di una coerenza narrativa, anche se illusoria.
In questo senso, Memento si inserisce nella più pura genealogia postmoderna: in un circolo ermeneutico infinito dove il segno rimanda sempre a un altro segno, in un differimento interminabile del significato; citando Lyotard, la grande narrazione dell’identità crolla sotto il peso di micro-racconti, soggettivi e autopoietici. Nolan non offre un punto di vista privilegiato, né un’interpretazione risolutiva: il film stesso è un oggetto ermeneutico instabile, che riflette la crisi del soggetto cartesiano e l’avvento dell’io frammentato e performativo.
In ultima analisi, Memento non è un film sulla memoria, ma un film-memoria, un palinsesto instabile di tracce, indizi, cancellature e riscritture, dove il vero non è che il falso in cui si è deciso di credere. Nolan ci ricorda che l’identità non è altro che il racconto che decidiamo di scriverci addosso. Ma se quel racconto è fondato su una menzogna, allora la domanda non è più “chi sono io?”, bensì: “quale menzogna mi è necessaria per continuare a esistere?”.
In questo enigma dolente e ineludibile, Memento tocca un grado raro di profondità filosofica e inquietudine estetica. È cinema che pensa, ma soprattutto, cinema che disfa il pensiero.