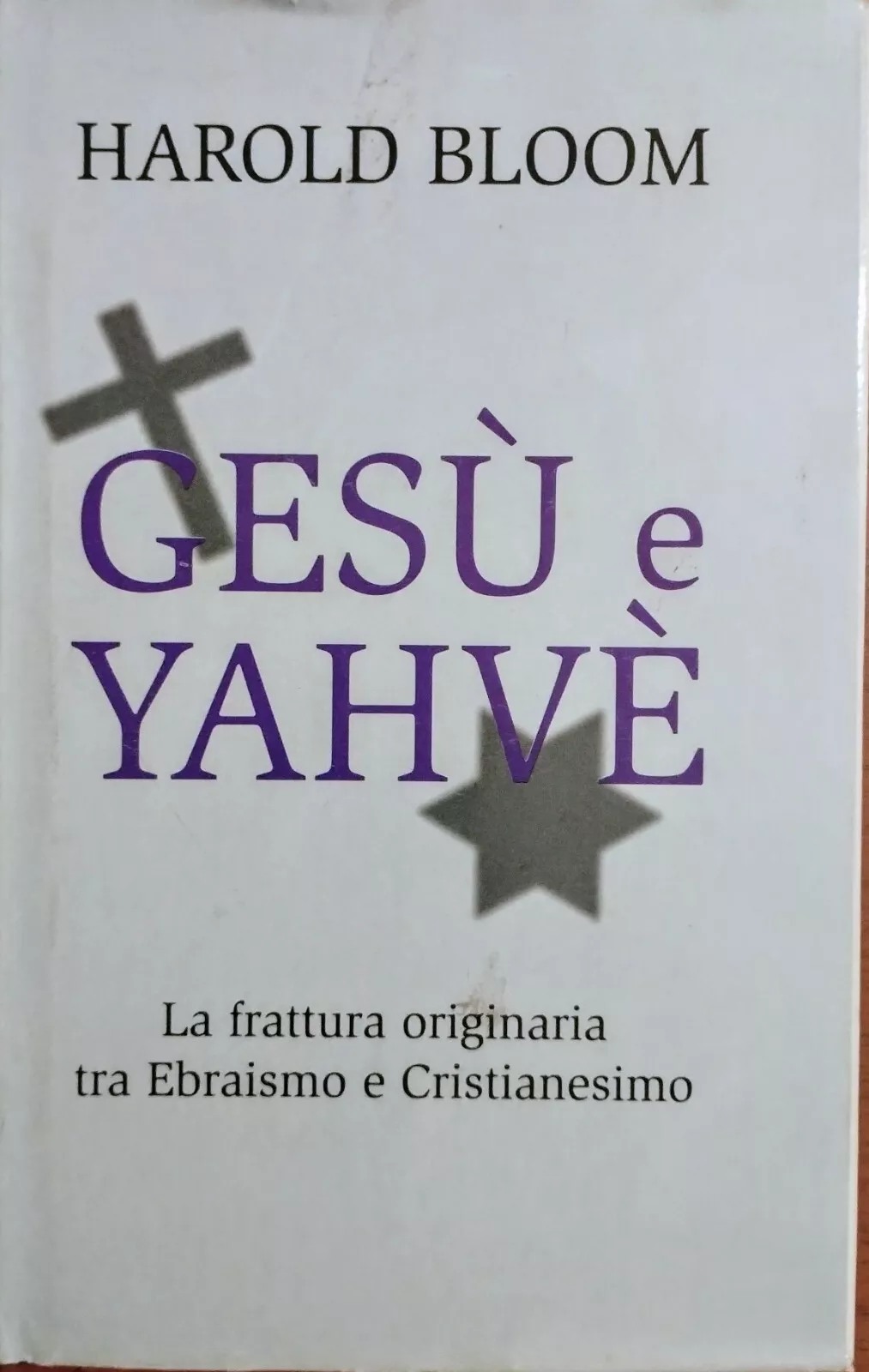Harold Bloom, in “Gesù e Yahvè”. Il nome divino (Jesus and Yahweh: The Names Divine), offre una delle sue più eccentriche e provocatorie incursioni nel territorio teologico, proseguendo quella linea di “critica delle influenze” che, traslata dal dominio letterario a quello religioso, diventa quasi una psicologia comparata delle divinità.
Bloom non è un teologo, e non finge di esserlo: è un lettore assoluto, un esegeta estetico, un iconoclasta della fede.
Nel libro, l’autore affronta la tensione, più che il dialogo, fra HaShem, il D-o ebraico delle Scritture, e Gesù, la figura cristiana che pretende di incarnarlo e insieme di superarlo.
Il risultato è un testo a metà fra midrash eretico, analisi letteraria e confessione spirituale di un ebreo scettico, intrappolato nella vertigine della propria cultura.
Il punto di forza principale di Bloom è la straordinaria lucidità con cui distingue il linguaggio della rivelazione da quello della letteratura. HaShem, nel suo sguardo, non è un simbolo, ma un personaggio dotato di furia, capriccio, ironia, perfino di un senso teatrale del potere; un D-o narrativamente vivo, quindi “più reale” del Gesù evangelico, che Bloom vede invece come un costrutto stilizzato, proiezione dell’evangelista Giovanni, la cui voce domina e dissolve quella del presunto protagonista.
Il Gesù di Bloom non parla: è parlato. È un riflesso, un dispositivo retorico che trasforma la concretezza del D-o biblico in una figura estetica, poetica, quasi “ellenistica”. In questa operazione, Bloom individua il nucleo della distanza fra ebraismo e cristianesimo: la sostituzione della voce con il logos, dell’evento con il racconto, dell’incontro con la metafora.
Ma se la forza del libro sta nella sua capacità di restituire alla Bibbia ebraica il suo carattere di testo vivo, polifonico, in cui il divino è presenza e non idea, il limite di Bloom è di natura speculare: la sua lettura, in quanto eminentemente estetica, rischia di ridurre il divino alla dimensione letteraria, di scambiare il potere della parola per la sostanza dell’essere.
Nella sua impazienza verso ogni teologia sistematica, Bloom finisce per sostituire un feticismo filologico all’atto di fede: HaShem non è più Colui che È, ma Colui che scrive (o che è scritto). È una visione potente, ma anche autocontraddittoria: un D-o senza trascendenza, confinato nel testo, come se l’unica eternità possibile fosse quella della pagina.
C’è poi un altro aspetto che rende il libro affascinante e irritante insieme: il tono oracolare e soggettivo con cui Bloom si arroga il diritto di giudicare la divinità, non come studioso ma come “lettore definitivo”. La sua “HaShemologia” è un atto d’amore e insieme di ribellione: l’ebreo che non prega più, ma non riesce a smettere di leggere. In ciò sta la sua grandezza: la consapevolezza che la letteratura è l’ultimo santuario del divino in un mondo secolarizzato. Tuttavia, nel suo narcisismo intellettuale, Bloom trasforma questa consapevolezza in un monologo, non in un dialogo e il suo libro, più che una teologia, è un soliloquio di un dio minore sull’assenza del Dio maggiore.
Il libro è un’opera di genio critico e presunzione teologica, un testo irregolare e abbagliante che illumina proprio perché non pretende di essere equilibrato. È un libro da cui si esce irritati ma arricchiti, come da una discussione con qualcuno che sbaglia in modo straordinariamente intelligente. Bloom sembra più in cerca di sopravvivere alla propria tradizione, di ascoltare ancora una volta la voce che parla dal roveto, anche se oggi, come egli stesso ammette, non vi è più nessuno disposto a rispondere “Hineni”.