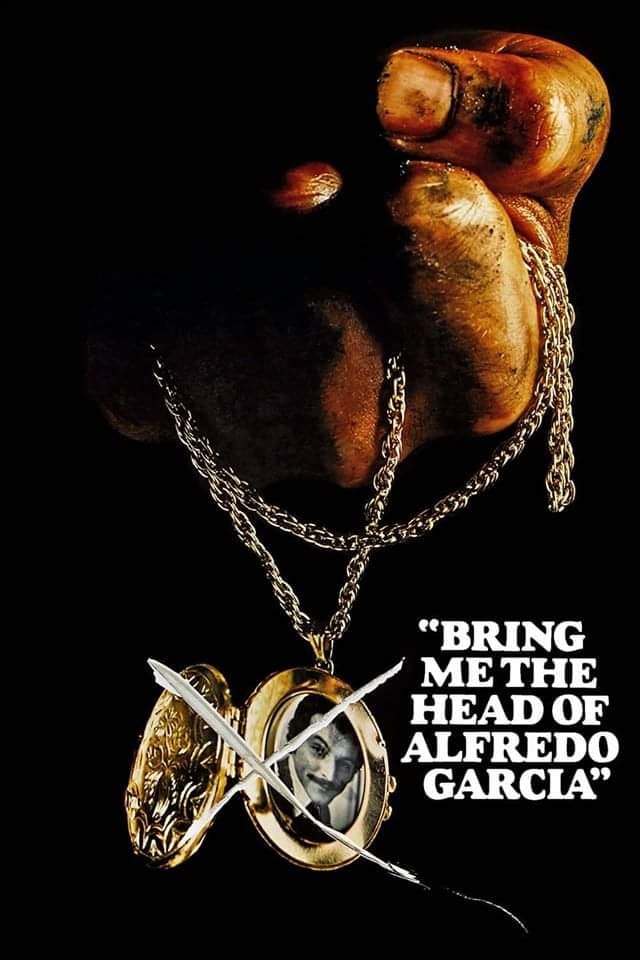Voglio la testa di García (1974), diretto da Sam Peckinpah, rappresenta uno dei vertici del cosiddetto tardo western contemporaneo, benché il film si collochi deliberatamente ai margini del genere, fino a dissolverlo. Peckinpah, nel suo periodo più estremo, costruisce un’opera rabbiosa, violenta, brutalmente pessimista, che trasforma la dinamica del viaggio in una traiettoria discendente, quasi un rito iniziatico rovesciato: non l’ascesa dell’eroe, ma la sua progressiva corrosione.
Ambientato in un Messico polveroso e crudele, il film assume i tratti di un on the road politico, sporco, privo di romanticismi, dove l’azione è contaminata dall’avidità, dal cinismo, dalla menzogna. Peckinpah realizza un impianto narrativo antimitico e antieroico, che cancella ogni residuo di nobiltà del West, sostituendolo con un’umanità esausta, predatoria, senza orizzonte di salvezza.
Al centro, un Warren Oates di forza titanica: figura tragica e disillusa, che attraversa il film come un relitto carico di dignità ferita, incapace tuttavia di sottrarsi al gorgo che lo inghiotte. L’intera vicenda, orchestrata con una crudezza visiva che sembra voler sfidare lo spettatore, procede come una discesa agli inferi priva di soluzioni, un tragitto senza ritorno.
Paradossalmente, all’epoca dell’uscita, l’opera fu classificata come uno dei dieci peggiori film mai realizzati: un giudizio che oggi appare non solo miope, ma quasi grottesco. Voglio la testa di García si impone infatti come un oggetto unico, irripetibile, un film da riconsiderare e rivedere, la cui ferocia e lucidità continuano a interpellare e a disturbare.
David Pacifici